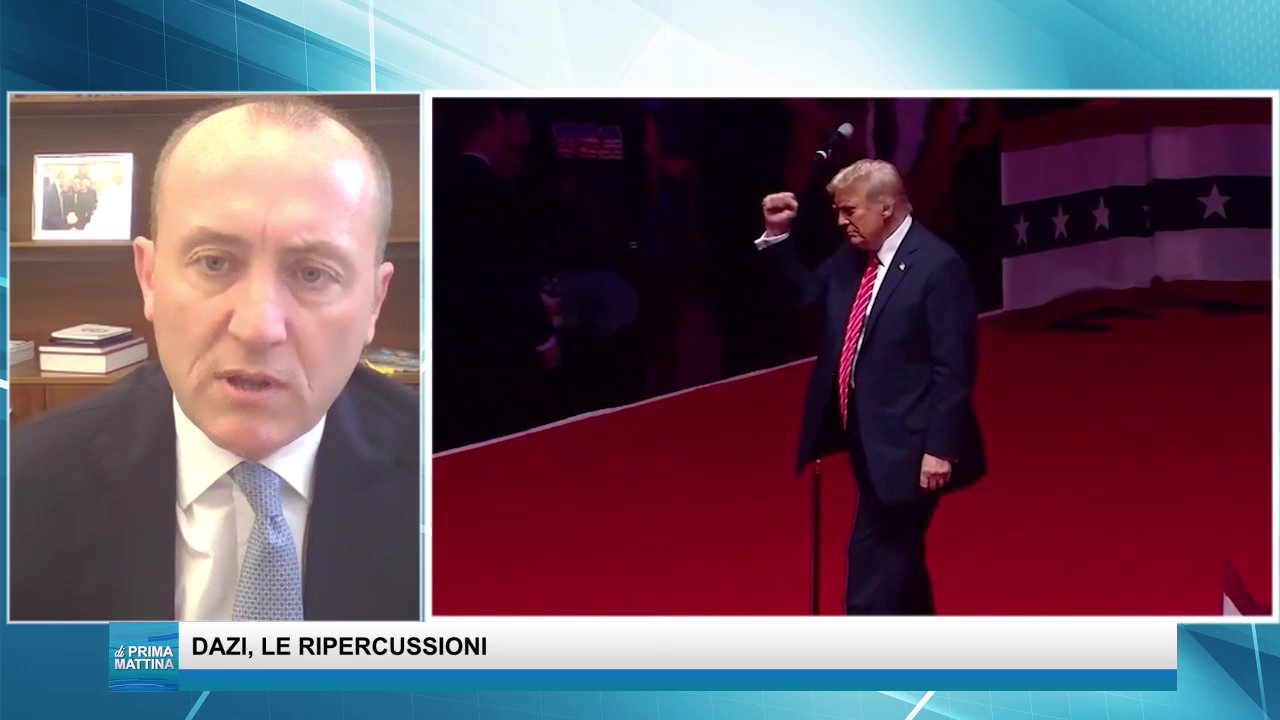La crisi della siderurgia vista dalle Pmi. Parla Pasquale Lampugnale, vp di Piccola Industria di Confindustria e ceo Sidersan

Tre le principali minacce per l’acciaio europeo e italiano. I dazi di Trump, il costo elevato dell’energia e il Carbon Border Adjustment Mechanism, che «non funziona». Quest’ultimo nasce per proteggere il comparto, ma impone agli importatori di ricostruire l’impronta carbonica dei prodotti. Che ha un costo, spesso insostenibile per le Pmi. Ma c’è tempo per modificalo prima che entri in vigore. Le politiche UE a supporto della siderurgia? Sono necessarie, ma non bastano. Come uscirne? Rafforzando le clausole di salvaguardia e abbattendo il costo dell’energia, anche investendo sul nucleare

Dazi americani che bussano alla frontiera; il Carbon Border Adjustment Mechanism (Cbam), la tassa sul carbonio che dovrebbe colpire l’acciaio inquinante importato proteggendo le nostre produzioni (ma al contrario genera oneri per le industrie); clausole di salvaguardia lasche. Tutti elementi che picchiano duro su una delle colonne portanti dell’industria europea, la siderurgia, che impiega oltre 2,3 milioni di persone ed è alla base di molteplici – se non tutte le – altre filiere, dall’automotive, all’energia rinnovabile, alle infrastrutture. Un’industria già indebolita dalla crisi del gas russo che ha fatto schizzare la bolletta energetica alle stelle, colpita dalla fortissima concorrenza cinese e che avrebbe bisogno di essere tutelata. Probabilmente non basterà neanche il Piano d’Azione Europeo per l’Acciaio appena annunciato da Bruxelles. Un piano che prevede, entro settembre, l’emanazione di misure di lungo termine per fronteggiare la sovracapacità globale (in particolare cinese), aggiornare le clausole di salvaguardia; revisionare il Cbam, estendendone anche l’ambito a determinati prodotti downstream a base di acciaio e alluminio e con ulteriori misure antielusione.
«Sono misure necessarie, ma non sufficienti. Soprattutto per le pmi dell’acciaio», dice a Industria Italiana Pasquale Lampugnale, ceo di Sidersan (pmi da 15 milioni di euro di fatturato che ha sede a Benevento ed è specializzata nella pre-lavorazione dell’acciaio) e vice presidente nazionale di Piccola Industria Confindustria con cui Industria Italiana ha provato a disegnare il futuro dell’acciaio europeo e italiano, focalizzandosi in particolare sulle piccole e medie imprese, che rischiano di finire strangolate per prime nella morsa delle criticità.
«Proprio il Cbam è il punto – continua Lampugnale – sull’importatore che acquista acciaio cinese dai trader ricade l’onere di dover ricostruire l’impronta carbonica del prodotto. E questa ricerca ha un costo, spesso insostenibile. Come pure è insostenibile il costo dell’energia: anche in tempi normali paghiamo il doppio di Francia e Spagna e il 50% in più della Germania. L’Ue dovrebbe agire su questo. E, ultimo, ma non meno importante, deve garantire la disponibilità di rottami ferrosi che sono la materia prima di base per produzione e decarbonizzazione della filiera». Una filiera in cui la pmi può giocare un ruolo strategico, con il contributo determinante proprio dell’Italia. Quanto all’Italia, la nostra siderurgia è uno dei settori portanti dell’economica domestica con un fatturato di 60 miliardi di euro e una produzione di 21,5 milioni di tonnellate di acciaio. Con colossi come Marcegaglia specializzata nella trasformazione dell’acciaio, produce tubi, piani, coils e prodotti in acciaio inossidabile; gruppo Arvedi, attivo nella produzione di acciaio laminato, tubi e prodotti piani; Afv Beltrame Group, con specializzazione nella produzione di laminati mercantili e profili speciali. E ancora, Acciaierie Venete con focus sulla produzione di acciai speciali destinati a vari settori industriali; e Feralpi Group con specializzazione nella produzione di acciai per l’edilizia e laminati.
D: Allora Lampugnale, quali sono oggi le minacce maggiori per la competitività della siderurgia europea?
R: Innanzitutto, l’eccesso di capacità produttiva globale, stimato dall’Ocse in oltre 550 milioni di tonnellate (quattro volte la produzione annua dell’UE), con Cina, Nord Africa e Sud-Est asiatico che esportano acciaio a prezzi spesso inferiori ai costi di produzione. In secondo luogo, i costi energetici elevati e l’impatto delle normative ambientali, che rischiano di erodere ulteriormente la capacità competitiva dell’industria siderurgica europea. Il Carbon Border Adjustment Mechanism (Cbam), introdotto per compensare le differenze di prezzo con i produttori extra-UE – che non sono soggetti alle regole stringenti del Green Deal – è ancora un meccanismo sperimentale e potrebbe non essere sufficiente a proteggere il settore dalle distorsioni del mercato globale.

D: Il Cbam è nelle intenzioni un meccanismo premiante per le nostre siderurgie. Ci spiega perché non funziona?
R: L’idea alla base del Carbon Border Adjustment Mechanism è applicare una tassa sulle importazioni di prodotti delle industrie di acciaio cemento e alluminio, che dipende dalla quantità di carbonio che è stata emessa durante la produzione. L’obiettivo è allineare i prezzi, evitando che i produttori europei, che già affrontano costi legati alle normative sul carbonio, siano svantaggiati dalla concorrenza di prodotti esteri che non pagano un prezzo simile per le loro emissioni. Nelle intenzioni, tutto meraviglioso. In pratica, il Cbam mette sotto pressione gli importatori. E se l’importatore è una piccola azienda che tipicamente acquista l’acciaio dai trader, si trova davanti a un problema enorme. L’importatore dovrebbe indicare nome, tipo di merce, emissioni equivalenti in CO₂: tutti oneri di gestione insostenibili per le Pmi. Su questo, come filiera e come Confindustria, abbiamo fatto una battaglia perché la Commissione nel Green Deal ha messo bandiera politica ma non ha preservato la competitività dell’Europa.

D: Però ci sono delle aperture alla revisione del Cbam proposte dalla Commissione Europea con la Bussola della Competitività. Come le valuta?
R: Ovviamente positivamente. La tassa sul carbonio importato dovrebbe entrare in vigore dal 2026, abbiamo tempo per migliorarla. Dobbiamo stare attenti al corto circuito che si genera. Molto coils viene importato dalla Cina ed è inevitabile. D’altronde noi siamo responsabili, come Europa, solo dell’8% delle emissioni globali, a fronte di sforzi enormi già compiuti per la decarbonizzazione e quindi alle aziende viene chiesto un po’ troppo. L’apertura con la Bussola della Competitività da parte della Commissione per una semplificazione è positiva. Ma dobbiamo capire poi che piega prenderà: la proposta di escludere le importazioni sotto 50 tonnellate non è sufficiente perché è asimmetrica, pur riducendo gli oneri per circa 180 mila imprese. Favorisce le minuterie metalliche o le piccole importazioni di acciaio, ma non è sufficiente.
D: E poi ci sono rischi nuovi, come quello rappresentato dai dazi americani. Quale impatto ci dobbiamo aspettare?
R: La stretta protezionistica degli Usa potrebbe colpire fino al 10% delle esportazioni cinesi di acciaio, un valore stimato in circa 7 miliardi. Il timore è che questi volumi potrebbero riversarsi sull’Unione Europea e quindi erodere quote di mercato e spingere i prezzi e conseguentemente la redditività verso il basso.

Sarà molto diverso da quanto accaduto durante il primo mandato di Trump, quando le tariffe sull’acciaio importato dall’Europa avevano generato una risposta dall’Unione in termini di dazi su prodotti americani e su auto e moto in particolare. Tuttavia, tali misure sono state parzialmente attenuate da quote di libero scambio che non sono state superate, limitando così l’impatto negativo sui prodotti statunitensi. Nonostante ciò, il mercato ha subito una contrazione, riducendo i margini di profitto delle aziende coinvolte. Oggi però le cose sono cambiate. Ci sono dinamiche che agiranno in maniera inedita.
D: Come sono mutate le dinamiche?
R: Nel contesto di un generale calo della produzione europea a favore della Cina (120 milioni di tonnellate contro oltre un miliardo), anche i numeri dell’export sono mutati. Le esportazioni italiane di acciaio verso gli Stati Uniti sono diminuite significativamente, passando da 600.000 tonnellate a 200.000 tonnellate in pochi anni. Questo rappresenta circa l’1,8% delle esportazioni totali dall’Italia e l’11% da tutta l’Europa, con una concentrazione su prodotti piani utilizzati principalmente nel settore automobilistico. Le tensioni commerciali comprimerebbero ulteriormente un settore già sotto pressione: e la riduzione dei margini di profitto sarebbe significativa. Forse fatale.
D: In definitiva quali misure specifiche dovrebbe adottare l’Unione Europea per proteggere i produttori locali?
R: Bisogna rafforzare le clausole di salvaguardia, per proteggere l’industria europea con misure che sono chiaramente allineate al mercato ordinario e mitigano gli effetti di sovraccapacità mondiale. Questo è il primo tema. Il secondo è la revisione del Cbam, di cui già abbiamo detto, e il terzo tema è quello energetico. Poi l’UE deve garantire la disponibilità di rottami ferrosi che sono la materia prima di base: dobbiamo conservare questa materia prima che è strategica per produzione e decarbonizzazione della filiera. Se il rottame che produciamo in Italia lo vendiamo al migliore offerente, ovunque esso sia, impoveriamo il paese.

D: Intanto a inizio marzo l’Europa ha avviato un dialogo strategico sull’acciaio e qualche giorno dopo ha confermato che entro il terzo trimestre pubblicherà nuove misure per proteggere la nostra siderurgia con un UE Steel Act. Quali potrebbero essere i benefici per la filiera italiana?
R: Lo Steel Action Plan è un bene. L’Europa è nata sull’acciaio e sul carbone; il fatto che venga presentato questo documento segnala che ci sia una presa di posizione importante a favore di questa industria spesso penalizzata. L’acciaio è una parte portante della nostra economia ed è un settore fornitore di quasi ogni altra industria. Le costruzioni valgono il 70% del consumo di acciaio, ma anche l’automotive consuma acciaio da stampaggio profondo. Il settore dà lavoro a 2,5 milioni di persone in Europa e circa 70mila in Italia dove vale circa 60 miliardi di euro.
D: In che misura l’Italia può trarre vantaggio da questo nuovo dialogo strategico?
R: L’Italia ha una filiera siderurgica particolarmente efficiente e sostenibile rispetto agli altri Paesi europei e non solo. Siamo i primi nel G7 per decarbonizzazione e circolarità, avendo ridotto le emissioni di CO₂ del 33% dal 2000 ad oggi. I primi per produzione di acciaio pro capite da forni elettrici e l’85% dell’acciaio italiano è realizzato da rottame che viene recuperato e rilavorato. Un piano europeo che rafforzi la competitività del settore può favorire la crescita delle nostre imprese, anche attraverso misure di supporto agli investimenti in tecnologie più avanzate, incentivi per la transizione energetica e una regolamentazione più equa del mercato delle materie prime. Inoltre, l’Italia può giocare un ruolo chiave nel promuovere l’inclusione delle Pmi nella filiera strategica dell’acciaio, chiedendo che il piano europeo tenga conto delle esigenze delle piccole e medie imprese, che rappresentano il cuore del nostro tessuto industriale. Un altro elemento cruciale sarà il supporto all’export, specialmente in un contesto in cui le tensioni commerciali globali stanno ridisegnando gli equilibri del mercato. Se l’Europa adotterà misure per riequilibrare i costi energetici e ridurre la pressione normativa sulle imprese, il settore italiano dell’acciaio potrà mantenere la propria competitività e rafforzare la sua posizione nel mercato globale.

D: Più concretamente cosa significa ridurre la pressione normativa?
R: Noi come piccole imprese auspicheremmo un alleggerimento degli adempimenti per le aziende che hanno la nostra dimensione. Il Piano Draghi per la competitività chiedeva riduzione degli oneri dal 25% al 50% per le Pmi. Se una Pmi deve avere oneri di bilancio di sostenibilità, misurazione di impronta carbonica sull’acciaio importato e così via, non ce la fa. Sono costi insostenibili: tanto che un solo rinvio di anno fa stimare un risparmio di 6-7 miliardi di euro.
D: Però non esiste ancora un obbligo specifico di redigere un bilancio di sostenibilità…
R: Non c’è obbligo di rendicontazione e di redigere bilancio di sostenibilità, ma se si lavora in una filiera o si hanno interlocuzioni con le banche, alle aziende viene di fatto chiesto di essere compliant con le norme di sostenibilità che verranno. Se fai componentistica per auto e fai marmitte, il settore deve essere riconvertito. Banche e filiera chiedono allora conto dei modi in cui rispetti i criteri Esg, c’è una pressione indiretta che spinge a muoversi comunque. Ed è trainata da una spinta ideologica europea che è condivisibile, ma non può essere forzata.

D: Anche perché abbiamo visto che queste forzature creano danni enormi, e neanche potano grossi risultati sul fronte Esg, lo dimostra il settore dell’auto
R: Per l’auto le attese sono che possa essere procrastinato il termine del 2035 per il passaggio all’elettrico, senza distruggere l’industria automobilistica europea. Ma la domanda è: siamo in tempo a fare una cosa del genere? Le aziende auto lavorano su orizzonti decennali e quindi le imprese auto avevano già avviato la trasformazione. L’obiettivo dovrebbe essere ora prorogare quel termine e aggiungere la neutralità tecnologica. Se riusciamo a fare questo, siamo ancora in tempo.
D: Intanto l’aumento dei costi energetici sta incidendo sulla capacità della siderurgia italiana di investire in tecnologie a basse emissioni di carbonio?
R: Sì, e vale per tutte le imprese, soprattutto queste energivore. Alla fine, si mira alla decarbonizzazione ma non si fa nulla per aiutare le industrie sul fronte dei costi dell’energia. Bisogna investire su fonti energetiche a basso costo e stiamo lavorando come sistema per raggiungere questo obiettivo. E vogliamo lavorare sul permitting per rendere veloci le installazioni e sulla cultura per spingere il nucleare in Italia. Ci vogliono dieci anni, però, nel frattempo, il rischio lo abbiamo delineato. Sta a noi cercare di farvi fronte.
D: A proposito di neutralità tecnologica: il nucleare in Italia ha qualche speranza di essere adottato o sarà per sempre un tabu?
R: Il presidente di Confindustria Orsini ha due fari strategici. Il primo è salvare l’auto, il secondo è proprio quello dell’energia nucleare. Negli ultimi due anni abbiamo subito Covid-19, guerra in Ucraina e poi crisi energetica che in alcuni casi in Italia ha visto i costi delle bollette di imprese e famiglie decuplicati. Ma, in ogni caso, paghiamo l’energia il doppio di Francia e Spagna e il 50% in più della Germania, anche in tempi normali. Questo gap immaginiamo di poterlo compensare con utilizzo di energie rinnovabili, anche perché il nostro paese può essere hub di eolico e fotovoltaico. Ma non è realistico: le rinnovabili sono importanti ma non bastano. È necessario aprire ai reattori nucleari di nuova generazione, che sono molto più sicuri di quelli che c’erano prima: ovviamente c’è bisogno di un orizzonte temporale ampio ed è un tema che ci dobbiamo porre sempre, non solo quando aumenta la bolletta. Rinnovabili e nucleare vanno di pari passo e vanno messi insieme.

Link all’articolo:
https://www.industriaitaliana.it/siderurgia-acciaio-nucleare-cbam-lampugnale-sidersan/